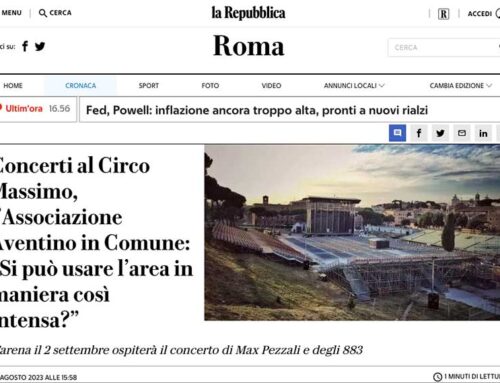Guido Calogero, illustre “Amico dell’Aventino”, Professore di storia della filosofia già dal 1931 nelle università di Firenze, di Pisa e, infine di Roma, dove prese l’insegnamento di filosofia teoretica, è stato uno dei maggiori filosofi dello scorso secolo.
Guido Calogero, illustre “Amico dell’Aventino”, Professore di storia della filosofia già dal 1931 nelle università di Firenze, di Pisa e, infine di Roma, dove prese l’insegnamento di filosofia teoretica, è stato uno dei maggiori filosofi dello scorso secolo.
Fu autore di molti libri, di storia della filosofia alcuni, di pura filosofia molti altri.
Studioso assai agguerrito della logica aristotelica e quindi della filosofia eleatica, autore di un compiuto sistema filosofico diviso nei tre volumi della Logica, dell’Etica e dell’Estetica, Calogero svolse in senso etico l’idealismo che aveva appreso alla scuola di Giovanni Gentile senza mai dimenticare il contributo di Benedetto Croce.
E la cui filosofia morale che, negli anni del fascismo, aveva trovato la sua espressione in quel libro di forte opposizione al regime che fu “La Scuola dell’Uomo” (1939), si definì a partire dagli anni cinquanta, come filosofia del dialogo, ossia come una concezione per la quale tutto può essere messo in discussione, tranne il dovere di discutere perché per negarlo e non discuterlo si dovrebbe comunque opporgli un rifiuto, e questo sarebbe un discuterlo.
Antifascista e fondatore del movimento liberal-socialista, patì negli anni quaranta il carcere e il confino di polizia, e, dopo la guerra, fu attivo, oltre che negli studi, nella politica.
Insegnò anche all’estero, in Canada, in Inghilterra e negli Stati Uniti.
“Fra il 1939 e il 1940, quando da qualche anno (il 1934, per l’esattezza) era professore di storia della filosofia nell’università di Pisa, Guido Calogero lasciò l’appartamento che, tempo addietro, aveva preso in affitto nella villa dell’Arcolaio a San Domenico di Fiesole, per trasferirsi a Roma, in una casa sita nella parte più alta dell’Aventino, e nella quale, eccezion fatta per i viaggi, i soggiorni in carcere e al confino di polizia, nonché quelli, più propizi, in Inghilterra e in America (Canada e Stati Uniti), sempre, fino al giorno della sua morte, abitò.
Risale a quel periodo la conoscenza che io ho di lui.
Il caso volle infatti che, quando la famiglia di Guido Calogero, la sua consorte Maria Comandini, i due figli, Laura (di dieci anni) e Francesco (di cinque), si stabilì a Roma, all’Aventino, da qualche anno la mia abitasse in una palazzina che si trova nella medesima via; e poiché allora, se non proprio quale Gabriele d’Annunzio l’aveva descritta in un capitolo del Piacere, questa parte di Roma era molto solitaria, ricca di giardini di prati e di angoli suggestivi, come quello, ad esempio, che si trova ad essere dominato dalla mole dell’antica basilica di Santa Sabina, così avvenne che con grande facilità, al pari di altri piccoli indigeni, con quei due ragazzini appena arrivati da Firenze anch’io stringessi rapporti di amicizia, di consuetudine, di giochi.
Debbo aggiungere che, nel mio ricordo, le figure dei nostri rispettivi genitori non rivestivano, per ciascuno di noi, grande importanza.
Ci erano familiari, senza dubbio.
Ma quanto erano consuete, altrettanto erano sbiadite; e, d’altra parte, eravamo tutti talmente giovani che poco doveva importarci se il padre del tale fosse un medico, oppure un avvocato, o magari, come poi di fatto avveniva per lo più, un giornalista.
Eppure, di Guido Calogero, che qualche volta mi accadeva di incontrare per la strada, o sull’autobus collegante il nostro quartiere con Piazza Venezia (o, nei periodi meno favorevoli, con Monte Savello), e che, sia per naturale timidezza, sia per giovanile maleducazione, mi guardavo bene dal salutare, conservo un ricordo abbastanza vivo; anzi, a pensarci bene, molto vivo..
Non solo o non tanto, perché, bianco com’era di capelli, questo trentacinquenne mi apparisse “vecchio”, e, non di meno, per la speditezza del passo, e l’energia dei gesti, altresì, curiosamente, giovane; ma anche e piuttosto, perché, a differenza di altri padri che incontravo per la strada in lui coglievo qualcosa di singolare, di indefinibile; forse, nel senso non deteriore della parola, di sfuggente e che tuttavia colpiva e lasciava il segno tanto che, ragazzino introverso e di difficile carattere, immaturo anche per i miei dodici anni, digiuno di ogni lettura che non fosse scolastica o infantile, per qualche misteriosa ragione, in quel signore dai capelli bianchi, e con quei singolari occhi grigi, mobilissimi dietro gli occhiali, e interrogativi piuttosto che indagatori, a me riuscisse tuttavia, e in qualche modo, di cogliere il tratto supremo di quelli che Giorgio Pasquali chiamava “gli uomini dello spirito”.
Di Pasquali, e degli uomini dello spirito, io, naturalmente, non sapevo nulla.
Come ho detto, ero persino più ignorante del lecito.
Ma in Calogero intuii un personaggio diverso da quelli che chiamavamo col nome di padre; un uomo posseduto da qualcosa di strano, che lo rendeva assorto e quasi distratto dalle normali occorrenze e incombenze della vita; un uomo che si muoveva in una dimensione inconsueta, e per noi, per me, impenetrabile.
Ci doveva essere in realtà qualcosa, nell’atmosfera del nostro quartiere, che rendeva non impossibile quell’intuizione.
Sebbene appartenessi ad una famiglia borghese, fondamentalmente apolitica (ma percorsa, per virtù di mia madre, da una vena estrosa di antifascismo estetizzante), lo spirito del luogo agiva, in modo strano ed obliquo, persino su di me che di politica non sapevo nulla; e all’improvviso, a volte, mi comunicava il brivido di sensazioni ignote.
Perché è vero: quel luogo possedeva, allora, uno spirito; e l’Aventino era un ben singolare quartiere.
Dominato fin dalla tarda antichità, e poi dagli inizi del nostro secolo, da alcune chiese e dai connessi conventi, nelle altre sue parti non era stato, agli esordi del novecento, che una degradante campagna di vigne, interrotta da qualche piccola casa di contadini; e la sua prima trasformazione in un quartiere residenziale avvenne, avanti lo scoppio della prima guerra mondiale, quando una cooperativa di giornalisti si costituì ed ottenne il permesso di costruirvi alcuni villini con giardino, che, in parte, sono, ancora oggi, quali allora erano.
Accadde, per altro (o così, almeno, si diceva ai tempi della mia infanzia), che, con l’avvento del fascismo, alcuni giornalisti favorevoli al nuovo regime, e da questo protetti, subentrassero nel possesso dei villini agli antichi assegnatari; parte dei quali, tuttavia, rimase nel quartiere che, in tal modo, divenne un luogo politicamente singolare, perché, abitato com’era da fascisti di rango e da antifascisti di provata fede, questo sotterraneo contrasto non poteva in qualche modo non trasmettersi ai suoi abitanti, almeno nel caso in cui questi possedessero un minimo di sensibilità e qualche immaginazione.”
(Gennaro Sasso, Filosofia e idealismo, III, Napoli, Bibliopolis, 1997, pp. 127-129)